Rudyard Kipling Il Ventre di Pietre
«E quello è l’Isonzo» disse l’ufficiale, quando fummo giunti all’estremità della pianura di Udine.
Si sarebbe detto che esso scaturisse dal Kashmir, con le frequenti sinuosità delle sue secche scialbe, che si inseguivano, giù per la corrente, in una danza vaporosa. Le acque, di color lattiginoso, odoravano della neve dei monti, mentre si avventavano contro le corde dei pontoni, allungati in modo da permettere molti piedi di altezza, a seconda del flusso delle acque. Un fiume nutrito di neve è altrettanto infido quanto un uomo ubriaco. L’odore caratteristico dei muli, del fumo acre del legno ardente ed una fila di carrette siciliane dalle ruote alte, coi loro fianchi dipinti a soggetti biblici, davano la illusione di una scena orientale. Ma il costone emergente dall’altra parte del fiume, e che sembrava così ripido, non era in realtà che un monticello piatto tra le montagne e non rassomigliava a nessun altro luogo sulla terra (Monte San Michele). Se i Matoppos si fossero accoppiati con i Karroo, avrebbero potuto appena concepire un tale aborto di pietrisco chiazzato e di lordume sminuzzato dalle intemperie. Lungo tutta la sua base, indifferenti oramai alle migliaia di soldati che erano lì intorno, allo stridio dei muli, al rauco tossir dei motori, al fracasso delle macchine e al calpestio delle carrette, giacevano, in teorie innumerevoli di cimiteri, quei morti italiani, che, per i primi, avevano resa accessibile la via alle maggiori altezze.
«Li abbiamo trasportati giù e li abbiamo seppelliti dopo ogni battaglia», disse l’ufficiale. «Vi furono molte battaglie. Reggimenti interi giacciono lì, là e… là! Alcuni di essi morirono nelle prime giornate, quando facevamo la guerra senza strade: altri morirono dopo, quando avevamo le strade, ma gli Austriaci avevano i cannoni. Altri, infine, morirono quando battemmo gli Austriaci. Guardate!»
Veramente, come dice il poeta, la battaglia è vinta dagli uomini che cadono. Dio sa quanti figli di madri dormono lungo il fiume, dinanzi a Gradisca, all’ombra della prima barriera dell’orrido Carso! Essi possono sentire il loro popolo indomito aprirsi col fuoco sempre più la strada verso Oriente e verso Trieste; la vallata dell’Isonzo moltiplica il ruggito dei pezzi pesanti intorno a Gorizia e alle montagne più a nord; e talvolta i velivoli nemici squarciano e sconvolgono quei luoghi di eterno riposo. I morti eroi giacciono, per così dire, in una fucina gigantesca, dove gli anelli della nuova Italia stanno ribadendosi sotto il fumo, la fiamma e il calore; calore che emana lì innanzi, dalle secche del fiume; calore che proviene dalle riarse alture elevantesi dietro a loro.
La strada si insinuava su per il monte, fra trincee morte, e reticolati di filo di ferro spinoso, rossi di ruggine sulla terra — simili ad «erpici capaci di attorcigliare corpi umani come fili di seta» — fra i consueti monticelli di sacchi di sabbia squarciati ed intorno a buche per cannoni vuote, e smussate ai cigli dalle intemperie delle stagioni. Non è facile scavar trincee sul Carso più di quel che si riesca a trovarvi acqua, perchè, alla profondità d’una palata sotto alla superficie, l’ingenerosa pietra si muta in cupa roccia e tutto deve essere perforato o schiantato. A quel tempo, poichè la primavera era stata umida, le pietre presentavano una vera fioritura di erbacce, che poi si essiccano completamente in estate, lasciando le rocce abbagliare e bruciare da sole. E, come se non bastasse tutta questa asprezza selvaggia, i versanti brulli e le cuspidi desolate erano incavate da numerose buche e da acquitrini, alcuni dei quali sembravano squisitamente tracciati da mano diabolica, per collocarvi mitragliatrici; altri, come piccoli crateri, erano capaci di contenere mortai da 33 centimetri e si aprivano fino al loro fondo, attraverso screpolature, in caverne asciutte, ove interi reggimenti possono nascondersi e donde possono essere snidati. Io vidi una di queste località, che era stata adibita da due battaglioni austriaci come riparo alle bombe, non lontano da un mucchio di muraglie di una grigia casa rovinata, le quali si incurvavano e parevano parlare insieme, nell’aria leggera, come spettri. Era ciò che rimaneva di un villaggio preso e ripreso. L’unica reliquia in esso vivente era una macchina che pompava l’acqua — attraverso i condotti, su per i monti, sopra i piani ed anche al di là; attraverso la nebbia lontana — alle truppe assetate, giacenti nelle trincee senz’acqua. «Qui abbiam fatto fuggire una volta gli Austriaci» — disse l’ufficiale. — «L’unica cosa che ci arrestò fu la mancanza d’acqua. I nostri uomini andarono avanti fino a quando non furono soffocati dalla polvere. Adesso questi condotti li seguono ovunque».
Girammo intorno alla più alta cima del costone e sbucammo fuori sul suo versante più riparato, ciò che gli Arabi chiamerebbero «Ventre di pietre». Non vi era ombra di verde, nulla ma soltanto roccia frantumata e rifrantumata, fino a perdita di vista, dallo scoppio delle granate.
Sulla terra, per quanto sconvolta, sia pure con qualche sforzo, si può sempre camminare; ma qui non v’era posto da mettere il piede; pareva di trovarsi in preda a un incubo. Neanche due frantumi erano identici l’uno all’altro, e quando si inciampava sull’orlo di una fossa scavata dall’esplosione di una granata, i cigli si sgretolavano e rotolavano crepitando. Grandi tombe comuni erano ammassate, ed arginate, lungo i loro fianchi, con muri di pietra. Sopra uno di questi cumuli di messi falciate dalla morte, qualcuno aveva posato un vecchio femore di color bruno. In quella località aleggiavano gli spiriti, nella calda luce del giorno, mentre la pietra fremeva sotto la canicola. Punte aride ed aguzze, come le coste di una mucca, si ergevano lungo la catena montuosa che si svolgeva sotto i nostri sguardi. Una di esse, che ci sottostava di pochi piedi, era stata presa e riperduta sei volte. «Ci spazzarono via con le mitragliatrici dalla località dove siamo — disse l’ufficiale; — così dovemmo conquistare prima questo punto più alto. Ci costò parecchio».
Egli ci raccontò di reggimenti distrutti, ricostituiti e ridistrutti, che raggiunsero soltanto alla loro terza o quarta resurrezione lo scopo che si erano prefissi i loro predecessori. Ci disse di morti nemici in gran quantità, sotterrati in talune località sotto alle risuonanti pietre e di una certa Divisione Honved ungherese la quale reclama, per diritto di sangue, la difesa di questa parte del Carso. Essi pure sbucano dalle rocce, muoiono e rinascono nuovamente, per essere nuovamente uccisi.
«Se voi entrate in questa buca, scavata da una granata — non vi consiglierei però di starvi troppo diritto — tenterò di dimostrarvi ciò che faremo nella nostra prossima spallata», disse l’ufficiale. — «Stiamo facendo preparativi» ed egli, con l’indice puntato spiegò come si sarebbe dovuto operare lungo taluni monti, che dominano certe strade e che conducono finalmente verso la parte settentrionale dell’Adriatico. — Questo mare si poteva scorgere in una chiazza d’argento opaco verso mezzogiorno, sotto alcuni cupi monti ombrosi, che coprivano la stessa Trieste. All’altezza del mento, un condotto, riscaldato dal sole, attraversava la buca ove ci trovavamo e l’acqua da esso trasportata sibilava come fa, al suo passaggio, una granata lontana. La spiegazione dell’ufficiale era sottolineata dal rombo dei vari grossi cannoni italiani, preparantisi in anticipo all’opera più difficile, che doveva venire più tardi. Poscia il terreno ebbe un sussulto pochi metri innanzi a noi, e i sassi aguzzi del Carso volarono via, in alto, come stormi di pernici.
«Mine!» — disse l’ufficiale serenamente, mentre i borghesi che si trovavano là rialzarono macchinalmente il colletto del loro soprabito; — «stanno lavorando sul versante ripido della giogaia; ma potevano ben avvertirci!»
Le mine esplosero in linea bene ordinata ed essendo impossibile di fuggire attraverso le pietre, dovemmo limitarci ad osservare le esplosioni, nella certezza che anche quelle decine di migliaia di morti che giacevano lì sotto, intorno, e dietro a noi, stessero ascoltando.
Nel frattempo udivamo una perforatrice pneumatica lavorar sotto terra, con rumore simile a battito di denti. «Non avrei mai pensato che si trovassero insieme tante pietre staccate».
— «Non son tutte staccate: vorremmo bene che così fossero. Sono, al contrario, molto solide. Venite a vedere». — Perdendo di vista la luce del sole, entrammo in una grande galleria tagliata nella roccia, ove alcuni binari erano posati in terra e ove degli uomini caricavano detriti su vagoncini. Una mezza, dozzina di feritoie davano la luce attraverso trenta piedi di roccia.
«Queste sono alcune nuove posizioni per cannoni forse da 180, forse da 220».
«E come fate voi a portare cannoni da 220 fin quassù?», domandai.
Egli sorrise un poco. Imparai più tardi, sulla montagna, la ragione di quel sorriso.
«A forza di braccia», rispose e si voltò all’Ufficiale del Genio, che dirigeva i lavori, per rimproverarlo di avere esploso mine senza avviso.
Scendemmo dal «Ventre di pietre» e quando ritornammo un’altra volta sul terreno piano, al di qua dell’Isonzo, ci voltammo ad osservarlo attraverso alle linee dei cimiteri che lo circondano. Esso era stato il primo ostacolo che l’Italia ha trovato sulla sua stessa soglia, dopo che ebbe varcato l’ampio Isonzo irrequieto, dove le truppe possono camminare ma camminare non è agevole.
| ◄ | Le strade di un esercito | ▲ | Podgora | ► |






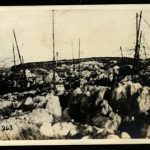


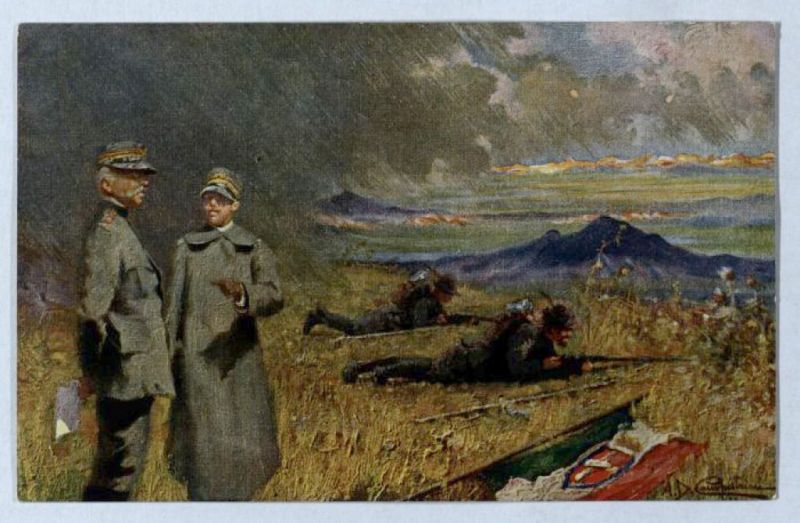



2 commenti su “Rudyard Kipling Il Ventre di Pietre”
“A forza di braccia”. Uomini di altri tempi, sofferenza portata al limite, solo pensare di scavare una trincea nel Carso é puro eroismo. Poi farlo sotto le bombe, il nemico che ti ha nel mirino, la fame, la sete, il tanfo di cadaveri al sole, è oltre ogni concezione umana. Non sapevo di Kipling, inviato di guerra.
Come non condividere le sue parole, erano uomini avvezzi a questi sforzi, troppi di loro non fecero ritorno, la miglior gioventù persa per sempre.. sarebbe importante almeno non ripetere gli stessi errori, “ma ancora tuona il cannone, ancora non è contenta di sangue la belva umana”, come dice Guccini..